Esiste un Deep State che tiene le leve del potere globale
FAVOREVOLE O CONTRARIO?
Il termine Deep State ha invaso il dibattito pubblico. A ogni evento inatteso — una sentenza inaspettata, una scelta militare controversa, un cambiamento di rotta economica — una parte dell’opinione pubblica risponde con la stessa domanda insinuante: “Chi comanda davvero?”. Non è solo una suggestione populista. Non è nemmeno, necessariamente, una teoria del complotto. È il riflesso di un mutamento profondo della percezione del potere. Quello che era una categoria usata in contesti specifici — come la Turchia degli anni ‘90, dove indicava i legami tra apparati militari, intelligence e criminalità organizzata — è oggi un concetto liquido, applicato ai sistemi democratici occidentali, agli organismi internazionali, alle grandi aziende tecnologiche, alle burocrazie statali e persino alla stampa. Ma cosa intendiamo esattamente per Deep State?
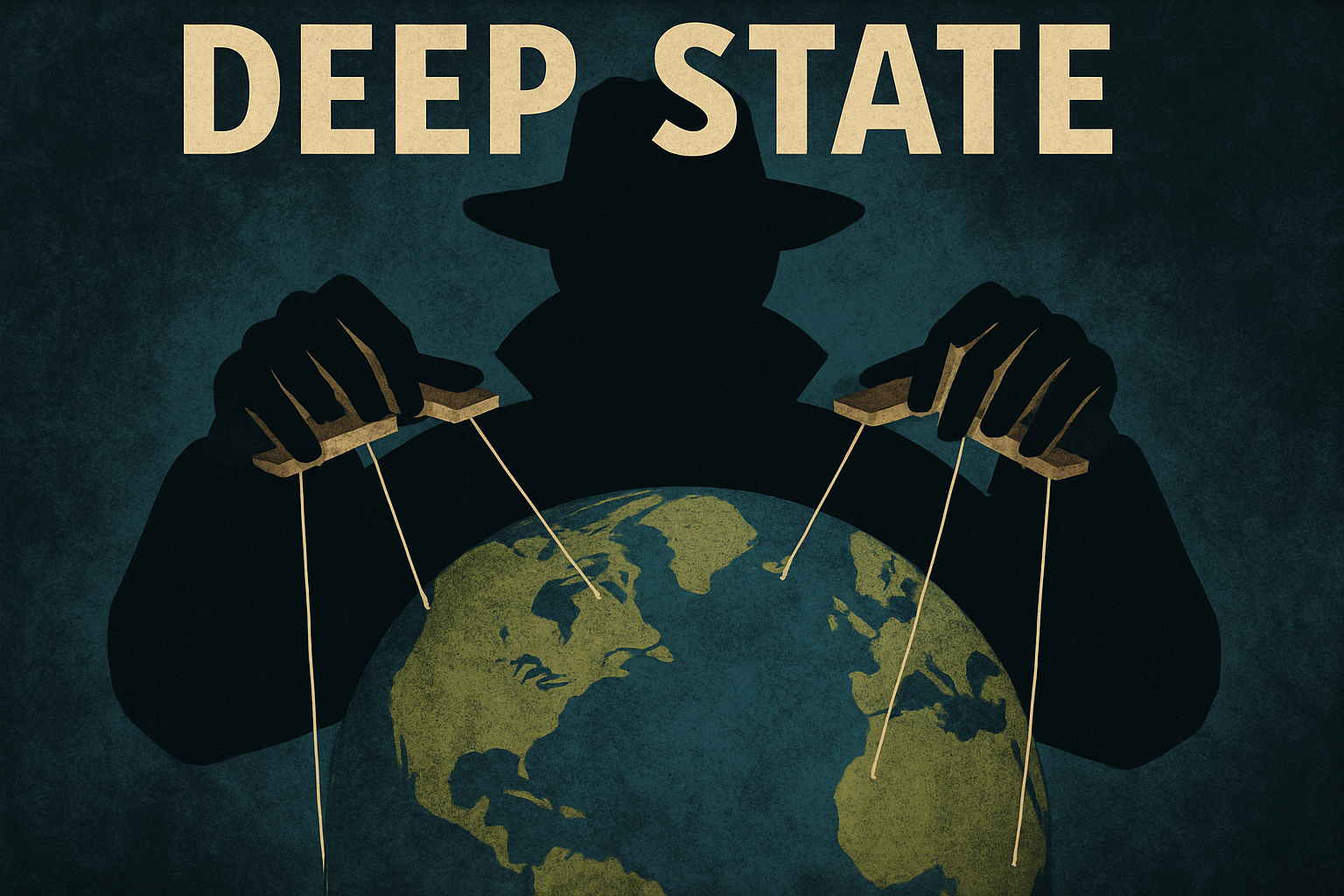
IL DIBATTITO IN 2 MINUTI:
Il concetto di “Deep State” negli Stati Uniti trova la sua concretizzazione più solida nella continuità del potere amministrativo, che spesso riesce a neutralizzare o deviare l’agenda politica di governi eletti.
Il Deep State è una narrazione politica funzionale a delegittimare l’avversario, disinnescare il controllo pubblico e svuotare la legalità delle sue garanzie.
Le Big Tech non sono solo imprese: sono infrastrutture sovrastatali, integrate negli apparati di sicurezza occidentali. È il nuovo volto del “Deep State”, quello tecnologico.
Il Deep State non è una teoria verificabile, né falsificabile, ed è quindi incompatibile con un’analisi scientifica del potere.
Con “Deep State” si pensa al caso americano. Tuttavia, il fenomeno ha assunto una dimensione transnazionale, è una rete di influenza globale che attraversa confini, governi e ordinamenti.
Ogni Stato moderno ha bisogno di strutture permanenti e specializzate. La macchina pubblica è una condizione necessaria per garantire la continuità dello Stato.
Nel sistema istituzionale, le decisioni per la sicurezza, l’economia, l’energia, la politica estera e la sorveglianza sono prese da strutture non elette, difficili da controllare.
Il Deep State è un’arma nelle guerre culturali , capace di mobilitare consenso, giustificare derive autoritarie e colpire selettivamente le istituzioni percepite come ostili.
Il Deep State è un potere invisibile strutturato nella burocrazia permanente
L'America ha eletto presidenti rivoluzionari, ma spesso ha governato con le stesse decisioni di sempre. Questa apparente contraddizione non nasce da dietrologie o complotti da romanzo, ma da un sistema molto più tangibile e istituzionalizzato: quello della burocrazia permanente. Il concetto di “Deep State” negli Stati Uniti trova la sua concretizzazione più solida proprio nella continuità del potere amministrativo, che spesso riesce a neutralizzare o deviare l’agenda politica di governi eletti. Lo sostiene Mike Lofgren, ex funzionario del Congresso americano, nel suo libro The Deep State: The Fall of the Constitution and the Rise of a Shadow Government (Viking, 2016). Per Lofgren, il Deep State non è una cupola segreta, ma una struttura visibile e sedimentata, composta da agenzie federali, dipartimenti militari, intelligence, enti giudiziari e burocrazie legislative che operano in modo autonomo, con una propria agenda. Secondo Lofgren, questa architettura è progettata per assicurare stabilità e continuità istituzionale. Tuttavia, la stabilità diventa rigidità quando le scelte del presidente o del Congresso vengono filtrate, rielaborate o ostacolate dalle tecnocrazie interne. È accaduto con Obama, quando la decisione di ritirare le truppe dall’Afghanistan fu di fatto disinnescata dai vertici militari. È accaduto con Trump, il quale, secondo numerose analisi, vide il suo tentativo di ristrutturare i rapporti con Mosca sabotato dalle stesse agenzie di sicurezza interna e dal Pentagono.
Questo potere burocratico si fonda su dimensioni strutturali impressionanti. Il solo Dipartimento della Difesa impiega circa 3 milioni di persone, più del totale della popolazione di alcuni Stati federati. Con una tale estensione, la burocrazia federale non è solo un’entità esecutiva, ma un sistema che produce e riproduce policy, influenza le priorità, seleziona cosa è "fattibile" e cosa non lo è.
Il potere delle agenzie si rafforza grazie a meccanismi opachi di gestione delle informazioni, tra cui la classificazione degli atti pubblici. Ogni anno, secondo “Osservatorio Globalizzazione”, vengono classificate oltre 180.000 decisioni che sfuggono così al controllo parlamentare e pubblico. Le agenzie operano in autonomia e la trasparenza viene aggirata tramite “classificazioni derivate”, dove perfino le motivazioni del segreto sono secretate. In questa dinamica, la democrazia rischia di ridursi a una rappresentazione formale, mentre il potere effettivo si concentra in una burocrazia tecnocratica che si autoriproduce e difende sé stessa. Il presidente può cambiare, ma i centri decisionali interni restano. La presidenza è l’epifenomeno visibile; il Deep State, invece, è la radice.
Questa tesi non accusa, ma descrive. Il Deep State non è un’entità malvagia, ma un effetto sistemico dell’eccessiva complessità e interdipendenza degli apparati. Tuttavia, quando tali apparati acquisiscono una volontà propria – scollegata dal mandato elettorale – si entra in una zona grigia che, per molti osservatori, rappresenta la vera crisi della democrazia contemporanea.
Nina Celli, 25 luglio 2025
Il Deep State è una costruzione ideologica, una narrazione utile a delegittimare le istituzioni
Non è casuale che il termine “Deep State” sia entrato nel lessico politico mondiale proprio in concomitanza con una crescente polarizzazione e sfiducia verso le istituzioni. Ma è proprio questa coincidenza a suggerire che il Deep State sia, prima ancora che una struttura reale, una narrazione politica funzionale a delegittimare l’avversario, disinnescare il controllo pubblico e svuotare la legalità delle sue garanzie.
L’origine concettuale del Deep State risale alla Turchia degli anni '90, dove veniva impiegato per descrivere i legami opachi tra militari, intelligence e criminalità organizzata. Ma la sua diffusione mediatica esplode con Donald Trump. Durante la sua prima campagna presidenziale e lungo tutto il mandato, il tycoon ha utilizzato il termine “Deep State” come dispositivo retorico, accusando FBI, CIA e giudici di sabotare il suo governo. È qui che il concetto muta: da teoria critica dello Stato si trasforma in strumento populista per delegittimare ogni contrappeso istituzionale. Lo evidenzia chiaramente Sidney Milkis su “Political Science Quarterly”, nel suo saggio del luglio 2025. L’autore sostiene che il concetto di Deep State sia stato piegato a una logica carismatica, nella quale ogni opposizione alla volontà presidenziale viene interpretata come “complotto delle élite”. In questo schema, l’intera architettura della divisione dei poteri – giustizia indipendente, burocrazia tecnica, agenzie autonome – viene percepita non come garanzia democratica, ma come ostacolo da rimuovere. Il Deep State diventa così una scusa per instaurare un potere personale.
La Brookings Institution, in un report del 2025 sul “Tracking Regulatory Changes”, mostra come la retorica anti-Deep State sia stata funzionale alla rimozione di decine di funzionari indipendenti, sostituiti con fedelissimi del presidente. Questo ha generato non un riequilibrio democratico, ma un'accelerazione dell’autoritarismo interno. L’esempio più eclatante è il tentativo di reintrodurre lo Schedule F, che consentirebbe di licenziare fino a 50.000 dipendenti pubblici senza tutele. Dietro il pretesto della lotta al Deep State, si cela una strategia per politicizzare l’amministrazione pubblica e abbattere ogni forma di professionalizzazione neutrale.
Persino nelle democrazie europee, come dimostrato dal “Koinè Journal”, l’uso della categoria Deep State spesso ricalca retoriche populiste. In Italia, ad esempio, viene evocato per giustificare ogni fallimento politico, spostando la colpa su “apparati deviati” mai dimostrati. Ma è una trappola semantica: se tutto è Deep State, allora nessuna responsabilità è più attribuibile ai governi eletti. La retorica del Deep State abolisce la distinzione tra legittimo dissenso e sabotaggio, tra istituzioni imparziali e nemici del popolo.
Un’altra evidenza proviene da Le Monde (2023), che analizza come Russia e gruppi complottisti occidentali abbiano fatto convergere le proprie narrative su un presunto Deep State globale, in grado di manipolare guerre, pandemie e finanza. La ricerca, condotta con l’IFRI, mostra che questa convergenza non è spontanea, ma parte di una strategia di destabilizzazione democratica, volta a seminare sfiducia nelle istituzioni e nella stampa.
In questo contesto, il Deep State diventa un contenitore retorico fluido, utile a giustificare qualsiasi accusa, qualsiasi epurazione, qualsiasi limitazione della legalità. Non esistono prove univoche di un coordinamento occulto e coerente tra agenzie, lobby e militari volto a governare contro la volontà popolare. Esiste, invece, un sistema complesso e imperfetto di contrappesi, procedure, professionalità e autonomia. Liquidarlo come Deep State è non solo fuorviante, ma profondamente pericoloso per la tenuta democratica.
Nina Celli, 25 luglio 2025
Esiste un Deep State tecnologico
Negli anni '90, la Silicon Valley veniva raccontata come la terra promessa della libertà individuale. I computer avrebbero liberato l’uomo dalla burocrazia, le reti digitali avrebbero democratizzato l’informazione, i social media avrebbero dato voce ai senza voce. Ma oggi, a distanza di trent’anni, quello stesso universo di innovazione si è trasformato in un nodo centrale di potere politico, militare e ideologico. Le Big Tech non sono più solo imprese: sono infrastrutture sovrastatali, integrate nel cuore degli apparati di sicurezza occidentali. È questo il nuovo volto del “Deep State”, quello tecnologico. A raccontarlo con precisione analitica è Paolo Gerbaudo, sociologo e autore del saggio Il nuovo Deep State tecnologico (Jacobin Italia, 2025). Gerbaudo descrive la fusione crescente tra aziende come Palantir, Meta, OpenAI, Anduril e lo Stato profondo securitario. Il punto di svolta simbolico è il 13 giugno 2025, quando dirigenti di Palantir, Meta e OpenAI hanno prestato giuramento come ufficiali dell’esercito americano, entrando formalmente nel Distaccamento 201 dell’Executive Innovation Corps. Non si tratta di collaborazioni occasionali. Palantir, fondata da Peter Thiel con finanziamenti della CIA (via In-Q-Tel), oggi ottiene quasi il 50% del proprio fatturato da contratti militari e di intelligence. I suoi software sono utilizzati per sorveglianza interna (ICE, FBI) e targeting militare (Ucraina, Gaza). Il sistema Gotham permette di tracciare relazioni, spostamenti e comportamenti predittivi di milioni di individui attraverso l’integrazione di dati bancari, telefonici, biometrici e digitali.
L’altro gigante emergente, Anduril Technologies, produce droni autonomi, sistemi di tracciamento AI, sorveglianza di frontiera e addestramento militare in realtà aumentata. Il fondatore, Palmer Luckey, si definisce “sionista radicale” e raccoglie fondi per Donald Trump. La sua azienda è valutata oltre 30 miliardi di dollari e opera in assenza di concorrenza, trasparenza o controllo democratico, grazie a contratti diretti con il Pentagono e partner NATO. Questa convergenza ha dato vita a quello che Gerbaudo definisce un “complesso militare-informatico”: una riedizione aggiornata del “military-industrial complex” denunciato nel 1961 da Dwight D. Eisenhower. Ma oggi, a differenza del passato, l’elemento centrale non è più la produzione bellica, bensì il controllo dei dati, la capacità di “vedere” e anticipare i comportamenti umani.
Le rivelazioni di Edward Snowden (2013) sul programma PRISM confermano che Google, Facebook, Microsoft, Apple e altri fornivano backdoor diretti alla NSA per l’accesso ai dati degli utenti. Oggi, grazie all’intelligenza artificiale, questo potere è ancora più raffinato: Palantir ha fornito a Israele strumenti predittivi di guerra e ai governi occidentali algoritmi per la repressione delle migrazioni (ICE, 2023–25).
Il Deep State tecnologico non agisce nell’ombra, ma al centro della sfera pubblica, in divise ufficiali e con finanziamenti statali. Le sue azioni sono giustificate dal linguaggio del “patriottismo”, della “difesa della democrazia”, della “lotta alle autocrazie”. Ma la democrazia che resta, avverte Gerbaudo, è quella filtrata dagli algoritmi, protetta dalle mura digitali e finanziata con appalti miliardari.
In questo contesto, la coincidenza tra Stato e impresa, tra codice e potere coercitivo, non è un’anomalia ma una strategia. I colossi digitali non solo collaborano con il Deep State: sono diventati parte costitutiva della sua nuova forma.
Nina Celli, 25 luglio 2025
L’esistenza del Deep State non è verificabile
La forza persuasiva del concetto di “Deep State” risiede nella sua capacità di adattarsi a ogni evento, ogni crisi, ogni deviazione dal corso previsto della politica. Ma proprio questa elasticità, che lo rende così attraente per media e retorica politica, è anche il suo più grave limite epistemologico: il Deep State non è una teoria verificabile, né falsificabile, ed è quindi incompatibile con un’analisi scientifica del potere.
Nel suo saggio pubblicato su “Origins” (Ohio State University, 2025), lo studioso Paul J. Croce osserva che la narrativa del Deep State, pur affondando le radici in fenomeni reali come la resilienza delle burocrazie e il lobbying privato, si trasforma rapidamente in un modello “totalizzante”. Ogni decisione istituzionale che non combacia con le aspettative dell’elettorato viene attribuita a un’entità nascosta, ma mai definita in modo coerente o dimostrabile. È ciò che Karl Popper avrebbe definito una teoria non falsificabile: non esiste alcun esperimento o fatto che possa smentirla, perché ogni prova contraria viene reinterpretata come conferma indiretta. Un esempio lampante è offerto dal caso dei Paradise Papers e Panama Papers, utilizzato da alcuni per “dimostrare” l’esistenza di un Deep State finanziario. Ma, come mostrato dallo studio pubblicato su “Scimex” (2025), questi meccanismi di elusione fiscale sono il risultato di sistemi legali e regolatori costruiti pubblicamente, spesso approvati dai parlamenti. Che siano iniqui o eticamente criticabili è fuori discussione, ma attribuirli a un governo ombra invisibile impedisce di analizzare le responsabilità politiche concrete e depotenzia ogni azione di riforma.
In un articolo di “Koinè Journal”, si osserva che il Deep State non è rappresentabile come un “soggetto unitario”, ma al massimo come una molteplicità di apparati con logiche e interessi spesso divergenti. L’intelligence, ad esempio, può agire in disaccordo con il Tesoro; il Dipartimento della Difesa può avere priorità opposte a quelle dell’amministrazione. Il concetto di Deep State, invece, presume un coordinamento centralizzato e coeso, che nella realtà è raramente riscontrabile.
L’argomentazione si complica ulteriormente quando si osservano le contraddizioni interne alla narrativa. Peter Thiel, fondatore di Palantir e finanziatore di Trump, è spesso descritto come parte del Deep State, ma anche come suo oppositore. Lo stesso Trump, che ha accusato il Deep State di boicottarlo, ha mantenuto in carica figure centrali dell’apparato federale. È il caso del direttore FBI Christopher Wray, che ha servito sia sotto Trump che Biden. Se il Deep State è ovunque e chiunque, allora non è più un concetto operativo, ma una narrazione simbolica.
Questo scivolamento semantico è analizzato anche da Slavoj Žižek su “Project Syndicate”: il Deep State diventa un contenitore psichico, un totem negativo verso cui proiettare il disagio per le contraddizioni della democrazia liberale. In questo senso, funziona come un mito politico moderno, ma non come categoria analitica o giuridica. Il problema non è solo teorico, ma pratico: una teoria non falsificabile è pericolosa in ambito istituzionale, perché può giustificare ogni abuso, ogni epurazione, ogni deroga alla legalità. Se il nemico è sempre invisibile e onnipresente, ogni eccezione diventa necessaria, ogni sospensione della legge è giustificata. È così che si passa dalla critica alla giustizia alla giustizia straordinaria; dalla sfiducia nel Parlamento alla disarticolazione costituzionale.
In definitiva, il concetto di Deep State, così come oggi viene impiegato in ambito pubblico e mediatico, non supera la soglia della dimostrabilità. È uno strumento retorico potente, ma anche una trappola epistemologica che alimenta la paranoia, ostacola il confronto democratico e impedisce l’elaborazione di soluzioni istituzionali trasparenti.
Nina Celli, 25 luglio 2025
Il Deep State è una rete globale sotto la guida egemonica americana
Quando si parla di “Deep State”, l’immaginario collettivo tende a focalizzarsi sul caso americano. Tuttavia, ciò che emerge dalle fonti più recenti è che il fenomeno ha assunto una dimensione transnazionale, strutturandosi come una rete di influenza globale che attraversa confini, governi e ordinamenti. Non si tratta più solo di una burocrazia interna, ma di un sistema parallelo di governance internazionale, fondato sull’intersezione tra intelligence, finanza offshore, think tank, contractor e alleanze strategiche tra élite economico-militari. Uno dei segnali più concreti di questa trasformazione si ritrova nello studio pubblicato da “Scimex” nel luglio 2025, che mostra come gli ultraricchi del mondo trasferiscano capitali in paradisi fiscali sulla base di fattori politici interni: instabilità, riforme patrimoniali, crisi istituzionali. L’evasione sistemica di controllo da parte degli Stati democratici non è un effetto casuale, ma il risultato di una strategia di protezione delle élite globali, favorita da reti legali, fiscali e informative che sfuggono a ogni mandato elettorale. Questo “sistema ombra” ha tutti i tratti funzionali di un Deep State su scala planetaria. A confermarlo sono anche le evidenze raccolte da Lucio Mamone nell’analisi dell’apparato giudiziario e di sicurezza USA. La Corte per la Sorveglianza dei Servizi Segreti Stranieri (FISA), ad esempio, opera senza controllo pubblico o parlamentare, autorizzando operazioni su base segreta che coinvolgono anche paesi esteri. Il giudizio politico è sostituito dalla valutazione tecnico-militare: è lo stesso meccanismo che regola l’extraterritorialità delle sanzioni USA, gestite dal Tesoro in accordo con Wall Street.
Ma il vero volto del Deep State globale si rivela nel sostegno diretto a governi esteri, attraverso una diplomazia parallela fatta di fondazioni, consiglieri, apparati militari e strumenti di sorveglianza. Le ricerche di “Limes” e “Koinè Journal” mostrano come gli apparati USA abbiano influenzato in modo strutturale la politica italiana e ucraina, sia durante la guerra fredda che nel conflitto russo-ucraino. L’Italia, in particolare, è descritta come “subordinata alla macchina strategica americana”, mentre l’Ucraina riceve impulsi non solo da Washington, ma da contractor e società private come Palantir e Anduril, attive in operazioni militari e di propaganda.
La logica transnazionale del Deep State si fonda su una concezione della sovranità post-statale. Come scrive Slavoj Žižek su “Project Syndicate”, oggi non c’è reale opposizione tra sinistra “woke” e destra radicale: entrambe, nei fatti, si muovono all’interno di un sistema capitalista iperconnesso, dove le istituzioni democratiche sono svuotate e i veri centri decisionali risiedono altrove. Il Deep State non è più solo lo Stato profondo nazionale, ma una forma ibrida di governance tecnocratica e finanziaria, che decide le guerre, i bilanci e le emergenze in autonomia.
Il caso israeliano è emblematico. Palantir, azienda americana con stretti legami con il Pentagono, ha firmato nel 2024 una partnership strategica con il governo israeliano, fornendo strumenti di targeting algoritmico impiegati durante la guerra a Gaza. La relatrice ONU Francesca Albanese ha incluso Palantir tra le aziende che “traggono profitto dal genocidio”. Ma queste operazioni non sono gestite da governi in senso tradizionale: sono frutto di una convergenza tra militari, industria privata e reti intelligence, che agiscono in sinergia, senza passare per le urne o i parlamenti.
Il Deep State globale si presenta non come una cospirazione nascosta, ma come una rete visibile di potere post-democratico, che utilizza la sicurezza come leva, la tecnologia come infrastruttura e il capitale come carburante. Governa senza governare, influenza senza dichiararsi, decide senza candidarsi. Proprio per questo è così difficile da controllare.
Nina Celli, 25 luglio 2025
Le burocrazie statali sono garanzia di continuità, non potere ombra
Ogni Stato moderno, per funzionare, ha bisogno di strutture permanenti e specializzate. Dalle agenzie fiscali ai servizi sanitari, dai ministeri della difesa agli enti di regolazione ambientale, la macchina pubblica è una condizione necessaria per garantire la continuità dello Stato al di là delle sue stagioni politiche. È questa infrastruttura che viene spesso etichettata, con eccessiva leggerezza, come “Deep State”. Ma dietro questa semplificazione si nasconde una grave mistificazione: quella di trasformare la professionalità amministrativa in un nemico invisibile, indebolendo uno dei pilastri della democrazia liberale.
Nell’articolo Il Deep State statunitense tra teorie cospirazioniste e controllo del potere (Orizzonti Politici, 2021), l’autore Massimiliano Garavalli spiega come l’apparato federale USA, composto da oltre 2 milioni di dipendenti civili, sia essenzialmente il motore operativo delle decisioni pubbliche. Il suo ruolo è implementare politiche, garantire stabilità amministrativa e fornire continuità tra le amministrazioni, non quello di sabotare o sostituire la sovranità politica. È proprio grazie a questa resilienza che, ad esempio, gli USA hanno potuto affrontare con efficienza transizioni traumatiche, come l’11 settembre o la pandemia da COVID-19, mantenendo attivi i servizi essenziali indipendentemente dai governi.
Questa funzione è descritta anche da Sidney Milkis su “Political Science Quarterly”, che distingue tra burocrazia responsabile e contro-potere illegittimo. Le agenzie come il CDC, l’FBI o la FEMA agiscono sotto vincoli normativi precisi, sono soggette a controlli ispettivi, audit, oversight congressuali e media scrutiny. Non operano nel buio, ma in un quadro di accountability, seppure migliorabile. Scambiare la loro permanenza per “resistenza al cambiamento” è un errore concettuale che distorce la fisiologia democratica, presentandola come patologia.
La retorica populista — usata sia da destra che da sinistra — spesso tende a dipingere queste strutture come “casta invisibile”, ma è una narrazione che ignora i dati. Secondo il rapporto Brookings (2025), l’89% dei dipendenti federali USA non cambia posizione con l'alternanza dei governi, proprio perché la loro funzione è tecnica, non politica. Questo è vero anche nei sistemi europei, dove le carriere apicali sono regolate da concorsi, vincoli deontologici e strutture meritocratiche, non da appartenenze partitiche.
Certo, possono esistere inefficienze, corporativismi, perfino deviazioni occasionali. Ma criminalizzare l’intera burocrazia come “Deep State” significa distruggere l’infrastruttura del servizio pubblico. L’alternativa sarebbe sostituirla con apparati fedeli, precari, ideologizzati, facilmente manipolabili dal potere politico. È la strada seguita nei regimi illiberali: spogliare lo Stato della sua autonomia tecnica per metterlo al servizio del leader di turno. Il caso di Trump lo dimostra chiaramente. Le sue accuse al Deep State hanno giustificato il licenziamento di figure apicali competenti, come il direttore FBI James Comey, creando vuoti di competenza e di sicurezza nazionale, come denunciato da “Il Sole 24 Ore” (2025). La sostituzione con figure ideologiche e inesperte ha reso gli apparati più fragili, non più responsabili.
La narrativa del Deep State, quindi, ha un effetto tossico sulla fiducia pubblica. Secondo il Pew Research Center, la fiducia degli americani nelle istituzioni è ai minimi storici proprio nei periodi in cui il discorso sul Deep State è più virulento. Il sospetto sistematico non rafforza la democrazia, ma la paralizza, disgrega, mette cittadini contro cittadini, trasformando ogni funzionario in un potenziale cospiratore. Le burocrazie non sono un potere occulto, ma un bene pubblico fragile e prezioso, il cui ruolo è assicurare che lo Stato continui a funzionare anche quando la politica cambia.
Nina Celli, 25 luglio 2025
Il Deep State è crisi della democrazia: la sovranità elettiva è neutralizzata
A ogni insediamento presidenziale, dopo i giuramenti e le celebrazioni, il nuovo capo dell’esecutivo si reca al briefing con i vertici dell’intelligence. Lì riceve il primo dossier completo su operazioni segrete, minacce asimmetriche, strategie in corso. Il potere formale della presidenza si scontra per la prima volta con il potere reale del sistema di sicurezza nazionale. Questa frizione tra sovranità elettiva e potere amministrativo-strategico è il cuore della riflessione sul Deep State come motore della crisi democratica contemporanea. Un sistema istituzionale in cui le decisioni fondamentali per la sicurezza, l’economia, l’energia, la politica estera e la sorveglianza vengono prese da strutture non elette, difficili da licenziare, ancor più da controllare. “Il Sole 24 Ore”, in un’inchiesta pubblicata nel gennaio 2025, ha messo in luce gli effetti di questa dinamica nella seconda amministrazione Trump. Il presidente ha iniziato una “purga” all’FBI, al Pentagono, alla NSA, sostituendo figure di lunga esperienza con fedelissimi senza background tecnico. Il tentativo dichiarato era quello di “liberare l’esecutivo dal Deep State”. Ma secondo l’editorialista Marco Valsania, il risultato immediato è stato un indebolimento delle capacità istituzionali, proprio mentre aumentavano le minacce esterne e la pressione del terrorismo internazionale (ISIS-K, Gaza, Libano). Lo Stato senza il suo “Stato profondo” si scopre vulnerabile; lo Stato con il suo Deep State è incontrollabile. È un paradosso che Mike Lofgren ha spiegato nel suo saggio fondamentale: il Deep State è una garanzia di stabilità, ma anche un dispositivo di autodifesa contro la volontà popolare. Quando un presidente eletto cerca di modificare gli assetti, gli apparati reagiscono. Non c’è bisogno di congiure: bastano filtraggi, ritardi, non-esecuzioni. Il presidente può firmare ordini esecutivi, ma è l’apparato federale che li interpreta, applica o “dimentica”. È lo stesso fenomeno descritto da “Orizzonti Politici” nel 2021: con più di 9 milioni di funzionari federali, il governo USA dispone di una macchina esecutiva che non risponde direttamente al Congresso o al popolo, ma a regole interne, gerarchie burocratiche e agende separate. La riforma del sistema civile proposta da Trump tramite lo “Schedule F” (analizzato su “Geopolitica.info”) mirava proprio a restituire potere al presidente, permettendogli di licenziare i funzionari “ostili”. Ma la proposta è stata criticata duramente da giuristi e costituzionalisti: rendere politica la burocrazia non significa controllarla, ma polarizzarla.
Anche in Europa, e in particolare in Italia, le dinamiche sono simili. Secondo “Koinè Journal”, l’influenza del Deep State americano si riflette nelle scelte strategiche italiane su energia, difesa e alleanze. Le strutture interne, dai ministeri alle agenzie, seguono linee transatlantiche indipendenti dalla maggioranza parlamentare, mantenendo relazioni, accordi e strategie al di fuori del controllo degli elettori. In questo contesto, la democrazia si svuota: non scompare, ma diventa una superficie retorica, sotto la quale agisce un altro tipo di razionalità. Una razionalità securitaria, algoritmica, basata su dati classificati e scenari di rischio che nessun cittadino può conoscere. La rappresentanza politica resta, ma è come una copertina colorata su un manuale scritto altrove.
Il Deep State non è dunque solo una distorsione: è una risposta sistemica all’instabilità della politica elettiva, una forma di governo parallelo che ha saputo sopravvivere a partiti, ideologie e rivoluzioni. Ma proprio questa resilienza rappresenta il vero limite della democrazia contemporanea: la sua incapacità di controllare ciò che fa a suo nome.
Nina Celli, 25 luglio 2025
Il Deep State è un’arma delle guerre culturali
Nell’epoca dell’infodemia, dove ogni frattura sociale è amplificata dai media e ogni narrazione trova conferma nella sua bolla ideologica, il “Deep State” è diventato qualcosa di più di una teoria. È diventato un marchio retorico, un’arma nelle guerre culturali contemporanee, capace di mobilitare consenso, giustificare derive autoritarie e colpire selettivamente le istituzioni percepite come ostili. Questa funzione del Deep State emerge con chiarezza nell’articolo Trump Is Breaking American Intelligence pubblicato su “Foreign Affairs” nel luglio 2025. L’autore, lo storico dell’intelligence David V. Gioe, documenta come Trump e i suoi alleati abbiano usato l’accusa di “Deep State” non per riformare l’apparato di sicurezza, ma per delegittimare ogni forma di dissenso istituzionale. L’accusa rivolta alle agenzie (FBI, CIA, NSA) è servita a neutralizzare rapporti sfavorevoli, a giustificare la rimozione di dirigenti competenti e a trasformare la sicurezza nazionale in un’arena di fedeltà personale.
La guerra al Deep State non ha prodotto maggiore trasparenza, ma una politicizzazione brutale dell’intelligence, con la nomina di consiglieri “lealisti” come Kash Patel e Pete Hegseth, privi di esperienza strategica. Come scrive “Il Sole 24 Ore”, ciò ha creato “vuoti di competenza” proprio nel momento in cui le minacce terroristiche e geopolitiche richiedevano lucidità e cooperazione. Il Deep State, dunque, non è stato smascherato: è stato sostituito da una rete ideologica orientata all’obbedienza, non all’efficacia.
Ma l’utilizzo strumentale del Deep State non è limitato agli USA. Su “Le Monde” (2023), William Audureau evidenzia come la retorica anti-Deep State sia stata assorbita dalla propaganda del Cremlino, alimentando una convergenza tra le teorie complottiste dell’alt-right americana e la disinformazione strategica russa. La narrativa è semplice e seducente: le democrazie occidentali sono manipolate da un’élite invisibile che vuole distruggere la sovranità dei popoli. In questa logica binaria, ogni forma di governance multilaterale (ONU, NATO, UE) diventa sospetta, ogni voce critica viene tacciata di complicità. Il problema è che questa costruzione retorica non distingue più tra critica legittima e sabotaggio immaginario. Un funzionario che rallenta un decreto è parte del Deep State. Un giornalista che solleva dubbi è pagato dall’élite. Un giudice che indaga un leader populista è l’agente di un complotto globale. Così, il Deep State diventa una macchina paranoica autoalimentata, che colpisce indistintamente ogni forma di dissenso o controllo. Lo ha spiegato con lucidità Slavoj Žižek su “Project Syndicate”: il mito del Deep State è la versione contemporanea del “Grande Altro” lacaniano, la proiezione inconscia di un ordine sovrastante che giustifica ogni fallimento politico. Quando il popolo vota ma nulla cambia, quando le promesse elettorali svaniscono, allora è colpa del Deep State. In questo modo, la responsabilità politica viene dissolta in una nuvola di sospetti e la partecipazione democratica si trasforma in sfiducia sistemica. Il prezzo è altissimo. Ogni volta che il Deep State viene evocato per zittire un’opposizione, si erode un pezzo di cultura costituzionale. Ogni volta che viene usato per giustificare epurazioni, si attacca la legittimità della divisione dei poteri. Ogni volta che diventa sinonimo di “nemico interno”, si avvelena il confronto pubblico. In nome della lotta all’oligarchia nascosta, si finisce per instaurare un’autorità senza limiti visibili.
Il Deep State è quindi più una strategia comunicativa che una realtà istituzionale. La sua forza non è nei dati, ma nel pathos. Non è una struttura, ma un’immagine: quella del potere che complotta dietro le quinte.
Nina Celli, 25 luglio 2025


